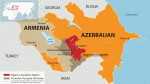Sull’agenzia di Stampa Nena-News sono usciti tre testi di Marco Santopadre relativi al recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian. Li riportiamo per intero. Chi volesse leggerli in originale li trova qua: parte 1, parte 2, parte 3. Buona lettura:
Parte 1: la tenaglia tra Russia e Turchia
È un’Armenia scioccata e amareggiata quella che accoglie decine di migliaia di profughi in fuga dai territori conquistati dalle truppe azere o ceduti a Baku dall’accordo sul cessate il fuoco del 9 novembre. I centomila sfollati che si stanno ammassando – dopo aver fatto terra bruciata dietro di sé – in un paese di soli tre milioni di abitanti, già vicino allo stremo per la crisi economica, l’emergenza Covid e il recente conflitto, cesseranno presto di essere oggetto della solidarietà e delle attenzioni retoriche dei leader nazionalisti.
Molti armeni arrabbiati e delusi cercano i responsabili della disfatta nelle alte sfere, gridando al tradimento del premier Pashinyan o dei comandi militari. Il 17 novembre, dopo le violente manifestazioni arrivate fin dentro il parlamento e la residenza del capo del governo, il presidente armeno Armen Sargsyan ha chiesto le dimissioni dell’esecutivo e la convocazioni di elezioni parlamentari anticipate. E intanto, si è dimesso il ministro degli Esteri Zohrab Mnatsakanyan.
Ma, al di là delle eventuali responsabilità dell’attuale classe dirigente nella gestione del conflitto e dei rapporti con le (vere o presunte) potenze alleate, l’Armenia prende atto sgomenta della sua debolezza e del suo isolamento. Sembrano trascorsi secoli da quando le milizie armene vittoriose sull’esercito di Baku resero effettiva l’indipendenza della Repubblica di Artsakh sulla maggior parte del Nagorno-Karabakh e conquistarono diverse province azere circostanti. All’inizio degli anni ’90 furono gli abitanti azeri di quei territori a trasformarsi in sfollati e a cercare rifugio ad est. Da quel momento la storia sembra essersi messa a correre e gli assetti interni e internazionali che avevano determinato la schiacciante vittoria armena sul suo storico rivale sono mutati.
L’Azerbaigian, una piccola potenza
L’ex repubblica sovietica dell’Azerbaigian, uscita con le ossa rotte dal conflitto con Erevan tra il 1991 e il 1994, è diventata una piccola potenza grazie ai generosi proventi del petrolio e del gas. Molta di questa ricchezza il paese l’ha investita in spese militari, facendo incetta di armi, munizioni ed equipaggiamenti di ultima generazione. Negli ultimi dieci anni il presidente Ilham Aliyev ha aumentato le spese per la difesa del 500%, modernizzando l’esercito di Baku e dotandolo di sistemi sofisticati e capaci di colpire a distanza, mentre le truppe armene si sono dovute accontentare spesso di armi obsolete.
A sostenere i preparativi bellici e le ansie di revanche dell’Azerbaigian nei confronti dell’Armenia sono stati soprattutto la Turchia e Israele, ma anche Mosca negli ultimi anni ha venduto più armi a Baku che a Erevan, nel tentativo (forse illusorio) di controbilanciare l’influenza di Ankara sulla repubblica turcofona.
Durante la recente crisi, l’Azerbaigian ha indubbiamente beneficiato della relazione di competizione/concertazione tra Turchia e Russia, impegnate in una complessa trattativa in vari quadranti. Per l’Armenia la tenaglia tra Russia e Turchia si è invece rivelata dolorosa, tanto che nella diaspora è tornato in primo piano il timore di un nuovo Medz Yeghern (termine che indica il genocidio del 1915-16) o comunque di una crollo del progetto nazionale armeno.
La Russia, in difesa
Come da tradizione, tra i due contendenti Mosca ha cercato di tenere una posizione di equilibrio e di tendenziale equidistanza, evitando di sostenere troppo nettamente l’Armenia che pure molti russi considerano una nazione cristiana e sorella, da difendere contro la minaccia turco-musulmana.
Durante il breve ma sanguinoso conflitto, un certo numero di soldati e cittadini russi, e non sempre di origini armene, hanno dato il loro contributo alla difesa della Repubblica di Artsakh. Ma la realpolitik ha consigliato a Putin una posizione più attendista, in nome degli interessi geopolitici della Russia nel Caucaso e non solo.
Dopo l’inizio dei combattimenti, il 27 settembre, Mosca ha evitato di fare la voce grossa. Avrebbe potuto, legata a Erevan da un accordo di assistenza militare nell’ambito del “Trattato di Sicurezza Collettiva”, e possedendo sul territorio armeno due basi militari – a Erebun e Gyumri – che ospitano migliaia di soldati, oltre a caccia, elicotteri e mezzi terrestri. Anche solo mostrando i muscoli, la Russia avrebbe potuto indurre gli azeri – e i loro sponsor turchi – a riconsiderare l’opportunità di un conflitto diretto con Ankara. Che però ha dovuto bilanciare la necessità di conservare (o recuperare) la tradizionale egemonia sull’Armenia con il rischio di rompere con un paese, l’Azerbaigian – con cui intrattiene solidi rapporti commerciali ed energetici – e soprattutto con la Turchia, partner e al tempo stesso competitore in numerosi teatri di conflitto dalla Siria alla Libia.
Troppo alto il rischio di rompere i difficili equilibri raggiunti negli ultimi anni con Ankara, mandando all’aria l’accordo sul TurkStream, la pipeline inaugurata lo scorso 8 gennaio che porta il gas russo in Turchia (8 miliardi di metri cubi l’anno) ma soprattutto nel Mediterraneo e in Europa. Un progetto vitale dopo il boicottaggio del SouthStream e la messa in standby del NorthStream 2, diretto in Germania, entrambi a causa delle sanzioni Usa.
Senza contare che Mosca continua a perseguire un sempre più verosimile sganciamento di Erdogan dall’Alleanza Atlantica e dalla sfera di Washington che ovviamente una rottura con la Turchia metterebbe in discussione. Se fosse intervenuta a favore dell’Armenia sulla base del Trattato di Sicurezza Collettiva, la Russia avrebbe fortemente contrariato altri paesi aderenti al patto militare come il Kazakistan, il Kirghizistan e il Tagikistan – legati alla Turchia da comuni origini etnolinguistiche e a maggioranza musulmana, sui quali Ankara esercita da tempo una crescente influenza, rischiandone lo sganciamento come già avvenuto per l’Uzbekistan e lo stesso Azerbaigian. D’altronde, durante il conflitto tra le due ex repubbliche sovietiche, il Kazakistan e il Kirghizistan hanno esplicitamente espresso il loro sostegno a Baku.
I russi non possono permettersi un sostegno univoco all’Armenia, pena la rinuncia al tentativo di rilanciare la propria egemonia nel Caucaso. D’altronde, il testo che accompagna l’accordo di cessate il fuoco e che porterà a una mutilazione territoriale della Repubblica di Artsakh, ricalca più o meno il cosiddetto “piano Lavrov”, la proposta di soluzione del contenzioso che la Russia ha difeso negli ultimi anni, fondata su un graduale ritiro delle forze armene dai territori azeri attorno al Nagorno-Karabakh conquistati nel conflitto del 91-94 e sull’invio nella regione di una missione di peace-keeping russa.
Il dispiegamento sulla linea di contatto, in particolare nel corridoio di Lachin – che dovrebbe continuare a congiungere l’Artsakh con la Repubblica Armena, garantendo una fondamentale continuità territoriale tra i due territori – di duemila militari russi incaricati di monitorare il rispetto del cessate il fuoco nei prossimi 5 anni rinnovabili, rappresenta una innegabile vittoria strategica per Mosca che estende così il suo controllo militare nell’area.
La Russia si dimostra fondamentale per la sopravvivenza dell’enclave armena in territorio azero (che rischiava seriamente di scomparire sotto i colpi dei droni, dei caccia e degli elicotteri di Baku) e per la stessa integrità territoriale della altrimenti indifesa Erevan, già garantita dalla presenza delle due basi russe. Il Cremlino ha tollerato l’avanzata azera sul territorio controllato dagli armeni ma è intervenuto per impedire una disfatta totale di questi ultimi quando i combattimenti lambivano ormai Stepanakert, la capitale dell’Artsakh.
Mosca si è confermata risolutiva per la cessazione del conflitto dopo il fallimento delle proposte di mediazione di Francia e Stati Uniti, soppiantando con la propria iniziativa il gruppo di Minsk dell’Osce, incaricato di una gestione multilaterale della crisi.
Le mosse di Mosca vanno lette anche all’interno dello scenario politico armeno come un tentativo di mettere in difficoltà il governo di Nikol Pashinyan e il suo schieramento politico filoccidentale, al potere dal 2018 in seguito alla cosiddetta “Rivoluzione di velluto” che provocò la rimozione di un esecutivo sicuramente più vicino agli interessi russi. Dalla sua ascesa l’ex giornalista ha ridotto al minimo l’integrazione militare e di intelligence con Mosca, ha epurato i comandi militari dagli elementi ritenuti troppo filo-russi, ha sospeso l’adesione di Erevan all’Unione Economica Eurasiatica promossa dalla Russia. Mosca vuole assolutamente evitare che l’Armenia segua le orme della Georgia, finita subito dopo la dissoluzione dell’Urss nell’orbita politica e militare statunitense.
Infine, la forma dell’accordo tripartito – i due contendenti più la Russia – sul cessate il fuoco esclude, anche se solo formalmente, la Turchia. Che però, come vedremo nella seconda parte dell’articolo, segna numerosi punti a suo vantaggio e potrà continuare a soffiare sul fuoco del nazionalismo azero prefigurando e preparando un eventuale secondo tempo del conflitto conclusosi il 9 novembre, diretto a riconquistare tutto il Nagorno-Karabakh, il cui status viene lasciato del tutto in sospeso dal vago accordo di cessate-il-fuoco.
L’innegabile successo diplomatico di Mosca si colloca in un contesto di incertezza ed ambiguità che lascia spazio alle rivendicazioni azere e turche ravvivate dal recente successo militare. Rivendicazioni che rappresentano una grave minaccia per gli armeni dell’Artsakh e per l’Armenia stessa, e che costituiscono un problema non indifferente per gli interessi di Mosca nella regione.
Inoltre, l’impiego da parte delle truppe azere di alcune migliaia di miliziani jihadisti siriani e di altri paesi aviotrasportati nel Caucaso dalla Libia e forse anche dalla Turchia testimonia della spregiudicatezza della strategia turca. Mosca, obbligata in questo frangente a una difficile convivenza/competizione con Ankara, dovrà attuare tutte le contromisure necessarie per evitare di trovarsi un’altra volta minacciata dal fondamentalismo islamico come già accaduto nei decenni scorsi prima in Afghanistan e poi nella propria area d’influenza, in Cecenia e in Daghestan.
Parte 2: l’assalto turco al Caucaso e il cinismo della UE
Non si allenta la tensione in Armenia tra le opposizioni e l’esecutivo del primo ministro Nikol Pashinyan, accusato di aver firmato una vera e propria resa nei confronti dell’Azerbaigian. I detrattori del premier sperano ora di ottenere la destituzione o quantomeno le dimissioni del premier e la convocazione di nuove elezioni, mentre il presidente Armen Sarkissian preme per la costituzione di un governo di unità nazionale.
Intanto gli sfollati che abbandonano le loro case nei territori conquistati da Baku o ceduti agli azeri dall’accordo siglato tra Armenia, Azerbaigian e Russia continuano a raggiungere Erevan, mentre la capitale della Repubblica di Artsakh, Stepanakert, è ormai una città fantasma. A partire sono anche migliaia di siriani e libanesi di origine armena che negli ultimi anni, per sfuggire alla guerra civile i primi e alla crisi economica e politica i secondi, si erano trasferiti nei territori strappati a Baku con la guerra del 91-94.
Alcuni sono stati attirati anche negli ultimi mesi dagli espliciti inviti provenienti da Pashinyan che, dopo gli iniziali toni concilianti nei confronti di una soluzione negoziale del conflitto, non ha esitato a esasperare il suo discorso nazionalista. Ed ora quelli che la propaganda azera e turca definisce “coloni” siriani e libanesi hanno perso tutto e si sono trasformati in profughi, o si ritrovano in un territorio assediato dalle truppe dell’Azerbaigian.
Soprattutto grazie ai droni kamikaze israeliani (Harop) e a quelli armati di missili a guida laser turchi (Bayraktar), le truppe azere hanno velocemente sbaragliato le milizie armene riconquistando dopo quasi 30 anni circa il 40% del Nagorno-Karabakh, a nord dell’enclave e soprattutto a sud, vicino al confine con l’Iran, dal quale l’Artsakh rimane ora completamente tagliato fuori.
Pur avendo evitato la catastrofe totale, quando i combattimenti lambivano ormai la periferia di Stepanakert, l’intervento pacificatore russo ha cristallizzato una situazione sul campo nettamente favorevole all’Azerbaigian. Il timore degli armeni è che Baku possa tentare di spazzare via ciò che rimane dell’Artsakh, anche se la presenza sul territorio di 2mila militari russi rappresenta, almeno per ora, un deterrente considerevole.
Non mancano quindi tra gli armeni le recriminazioni nei confronti della strategia di Mosca, accusata di essere intervenuta troppo tardi e di tenere il piede in due scarpe per non rompere con Baku e Ankara. Alcune delle correnti più radicali del nazionalismo armeno potrebbero accentuare la propria distanza dalla Russia, che pure rimane l’unico reale garante all’integrità territoriale e all’esistenza stessa dell’Armenia. Un diffuso disincanto nei confronti del soffocante e al tempo stesso altalenante abbraccio russo potrebbe favorire agevolare l’apertura di eventuali spazi di manovra per altre potenze, prime tra tutte la Francia.
Gli appetiti francesi e il cinismo dell’Ue
Nei giorni scorsi alcuni aerei carichi di aiuti umanitari sono partiti da Parigi alla volta di Erevan, mentre il Senato francese votava a stragrande maggioranza (con un solo voto contrario e l’astensione di En Marche, il partito di Macron) una risoluzione che chiede all’esecutivo di riconoscere la sovranità dell’Armenia sul Nagorno-Karabakh.
La Francia ospita più di 600mila armeni, e negli ultimi mesi è stata protagonista di una feroce polemica con la Turchia dopo gli strali di Macron contro quello che ha definito il “separatismo islamico” nell’esagono, sullo sfondo della competizione tra i due paesi nell’Egeo; in passato, inoltre, la scelta di Parigi di riconoscere ufficialmente il genocidio armeno aveva mandato Erdoğan su tutte le furie. La Francia tenta di recuperare un minimo di ruolo nel Caucaso e il suo storico ascendente sull’Armenia, dopo che durante il conflitto con l’Azerbaigian il suo tentativo di mediazione è stato ignorato e il gruppo di Minsk dell’OSCE al quale appartiene, insieme a Russia e Stati Uniti, è stato completamente scavalcato dall’iniziativa di Mosca.
Dichiarazioni roboanti a parte, però, Parigi è allineata alla posizione di equidistanza che l’Unione Europea ha adottato nell’ennesimo conflitto caucasico. Bruxelles ha stretto vari accordi con Baku per assicurarsi forniture di gas che rendano l’Ue meno dipendente dalle esportazioni della Federazione Russa. Sono numerosi i corridoi energetici e commerciali che collegano l’Azerbaigian alla Georgia e alla Turchia, bypassando i corridoi russi: oltre al gasdotto transanatolico e a quello Baku-Tbilisi-Erzurum,ci sono anche l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars.
Nelle scorse settimane è entrato poi in funzione il TAP (Trans Adriatic Pipeline), il metanodotto che porta il gas azero estratto nel giacimento offshore di Shah Deniz II, nel Mar Caspio, fino al Salento, dopo aver attraversato Georgia, Turchia, Grecia e Albania.
Per quanto indebolita dal crollo del prezzo degli idrocarburi, l’Azerbaigian può contare su circa mille miliardi di metri cubi di riserve di gas naturale e su sette miliardi di barili di riserve petrolifere complessive, e costituisce quindi un partner assai più appetibile e interessante della piccola Armenia.
Le esportazioni dell’Azerbaigian valgono circa 15 miliardi di dollari all’anno. L’Italia è il principale partner commerciale dell’Azerbaigian, con un interscambio pari a quasi sei miliardi di dollari annui, mentre il volume degli scambi tra Baku e Ankara si ferma, per ora, a neanche due miliardi. L’italiana Leonardo ha venduto all’Azerbaigian gli aerei d’addestramento M 346 e spera di piazzare anche la versione da combattimento.
Non stupiscono quindi le parole di circostanza pronunciate dal ministro degli Esteri Di Maio a proposito del conflitto azero-armeno e la generale accondiscendenza dell’esecutivo italiano nei confronti dell’espansionismo turco e delle continue provocazioni di Ankara.
L’assalto turco al Caucaso
Se dal punto di vista formale il vincitore del recente conflitto è l’Azerbaigian, sul piano internazionale ad avvantaggiarsene è soprattutto la Turchia.
Il regime di Erdoğan ha adeguatamente preparato le forze armate azere rifornendole di droni e di altri armamenti moderni che hanno reso l’arsenale armeno, per lo più di provenienza russa, in gran parte obsoleto.
Come già accennato, sono stati soprattutto i droni in dotazione all’esercito azero a fare la differenza, permettendo a Baku di eliminare in pochi giorni centinaia di pezzi di artiglieria e di tank armeni, oltre a varie batterie antieree, lasciando le truppe di Erevan e Stepanakert indifese. Le ultime forniture di droni turchi – per un valore di circa 64 milioni – sono arrivate a Baku poche settimane prima dell’inizio del conflitto.
Un’inchiesta del giornalista Andrés Mourenza pubblicata dal quotidiano spagnolo El País ricorda come la maggior parte dei droni forniti all’Azerbaigian siano stati prodotti dalla Baykar Technologies di Selçuk Bayraktar, genero del presidente Erdoğan. Con un costo medio di cinque milioni, un TB2 della Baykar è assai più economico di un caccia (che ne costa anche 100) e può condurre bombardamenti altrettanto micidiali senza oltretutto esporre i piloti ad alcun rischio, essendo gestito da remoto.
I sistemi di difesa antiaerea armeni, compreso il russo “Repellent” studiato appositamente per contrastare i droni, si sono dimostrati in gran parte inefficaci contro i TB2 turchi e gli Harop israeliani. L’ottima performance realizzata in Nagorno-Karabakh costituisce un ottimo spot per l’azienda del genero di Erdoğan, che dopo aver venduto vari esemplari all’esercito turco (già impiegati contro i curdi e le truppe siriane) e alle milizie jihadiste in Siria e in Libia, ora aspira a ritagliarsi altre fette di mercato competendo con i giganti americani, russi e cinesi.
Senza intervenire ufficialmente, Ankara ha inviato al fronte propri consiglieri militari, e soprattutto ha schierato migliaia di mercenari jihadisti – le stime più verosimili parlano di duemila – reclutati e addestrati nei territori del Nord della Siria che Ankara ha occupato nell’ottobre del 2019 con l’operazione “Sorgente di Pace”.
Dopo aver combattuto in Libia sempre per conto di Ankara, a essere impiegati in prima linea risparmiando così ingenti perdite alle truppe azere sono stati i miliziani della “Divisione Hamza” e delle brigate “Sultan Murad” e “Sultan Suleiman Chan”, in alcuni casi spediti a Baku qualche giorno prima dell’inizio dei combattimenti, a dimostrazione della premeditazione che ha guidato la strategia turco-azera.
D’altronde già durante il lungo conflitto all’inizio degli anni ’90, mujaheddin afghani, volontari ceceni, Lupi Grigi turchi e miliziani bosniaci combatterono a fianco dell’esercito dell’Azerbaigian, mentre a dar man forte agli armeni ci pensarono soprattutto cosacchi russi e ucraini e volontari provenienti da Ossezia e Grecia.
Dalla fine di luglio all’inizio di agosto di quest’anno, l’esercito turco ha condotto imponenti esercitazioni congiunte con quello azero, con il coinvolgimento di truppe di terra, veicoli blindati, artiglieria, aviazione militare e della contraerea.
Durante i combattimenti Erdoğan ha incitato più volte Ilham Aliyev a non fermarsi, e a riprendersi non solo le province azere conquistate da Erevan nel 91-94, ma anche lo stesso Nagorno-Karabakh. Opponendosi fino a quando ha potuto a qualsiasi tregua, il “sultano” ha preteso di sedere al tavolo negoziale come parte in causa e ora si prepara a mandare soldati turchi sul terreno in qualità di peacekeepers.
Per quanto la Russia, attraverso il cessate-il-fuoco del 9 novembre, abbia ristabilito il proprio ruolo di primus inter pares nell’area, estendendo la propria presenza militare al Nagorno-Karabakh e riuscendo ad escludere la Turchia dalla firma dell’accordo, è evidente che Ankara è riuscita a penetrare di prepotenza nel “cortile di casa” di Mosca, ridimensionando l’influenza di quest’ultima nello spazio geopolitico ex sovietico.
Com’era accaduto già nel quadrante siriano ed in quello libico, la Russia è di fatto costretta ad una coabitazione competitiva con il progetto neo-ottomano di Erdoğan, che dopo alterne vicende e numerosi passi falsi soprattutto in Egitto, in Tunisia e nella stessa Siria, si protende ora verso oriente, alla ricerca di una maggiore egemonia nei confronti delle varie repubbliche ex sovietiche turcofone e islamiche.
La vittoria sull’Armenia rappresenta una boccata d’ossigeno per il “sultano” che può usarla per puntellare la sua popolarità in patria, erosa dalla crisi economica aggravata e allungata dall’emergenza Covid, facendo appello al trasversale nazionalismo del panorama politico turco, rinfocolato dalle nuove opportunità panturche.
Anche dal punto di vista economico Ankara potrebbe trarre vantaggio dall’avventura armena. Il cessate il fuoco prevede la realizzazione, attraversando il territorio armeno, di una via di collegamento che congiunga l’Azerbaigian con l’enclave rappresentata dalla Repubblica Autonoma di Naxçıvan, con cui Ankara condivide un breve tratto di frontiera. Ammesso che l’Armenia ne consenta la realizzazione, la Turchia potrebbe così aprirsi un prezioso corridoio strategico fino al Mar Caspio, e da lì proiettarsi ulteriormente verso est.
Mentre la SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) potrebbe sommare nuovi investimenti a quelli già realizzati in Turchia, ben 19 miliardi di dollari in raffinerie e società di distribuzione dei prodotti petroliferi, il debito contratto da Baku con Ankara per sostenere lo sforzo bellico rappresenta per quest’ultima un’ulteriore occasione per rafforzare la propria influenza sulla “nazione sorella”.
Parte 3: la prudenza dell’IRAN e il ruolo di Israele
Venerdì scorso migliaia di persone – 10 mila per l’Afp e decine di migliaia per l’agenzia russa Interfax – hanno sfilato in corteo a Erevan chiedendo le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan, al grido di “Nikol traditore”. Si tratta dell’ennesima protesta contro il governo che lo scorso 9 novembre, dopo sei settimane di sanguinosi combattimenti, ha siglato un cessate-il-fuoco con l’Azerbaigian, mediato dalla Russia, che non solo ha comportato la perdita di circa il 40% del territorio dell’enclave armena dell’Artsakh, ma anche di tutte le province azere conquistate da Erevan nella guerra del ’91-’94. La cessione dei diversi territori a Baku comporta anche la perdita della maggior parte della miniera d’oro di Sotik, nel distretto di Kelbajar, gestita dalla russa GeoPro Mining Gold e che rappresentava un’importante fonte d’introiti per le casse armene.
Da parte sua, invece, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il proprio apprezzamento per il premier armeno Pashinyan, il cui operato è invece considerato catastrofico da molti suoi concittadini, parte dei quali lo aveva sostenuto nel 2018 quando, grazie alla filoccidentale “Rivoluzione di velluto”, aveva preso il potere dopo la rimozione di un esecutivo vicino proprio a Mosca. «Il governo armeno è stato costretto a prendere una decisione difficile ma necessaria» ha detto Putin nel corso di una videoconferenza dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CTSC), di cui fanno parte Erevan e Mosca. «Queste decisioni sono state dolorose ed hanno richiesto coraggio personale da parte del primo ministro armeno» ha continuato Putin, assicurando che ora il compito della Russia «è quello di sostenere lui e la sua squadra per organizzare una vita pacifica in Nagorno-Karabakh».
Ma il presidente russo non si è limitato a sostenere apertamente il suo ex rivale, che ora cerca a Mosca una sponda dalla quale per anni ha tentato di distanziarsi. Putin ha anche chiesto a tutti gli stati membri del patto di assistenza militare – che comprende anche Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan – di sostenere Pashinyan, contestato da una parte della popolazione armena e dalle opposizioni proprio per aver aderito al piano preparato dalla Russia, che oltre alla mutilazione territoriale prevede anche lo schieramento in Nagorno-Karabakh – già avvenuto – di 2000 militari russi. Pashinyan, a sua volta, ha ringraziato Mosca ed ha definito le forze di pace russe «una garanzia per la sicurezza nella regione», sottolineando il “ruolo decisivo” di Putin nel “fermare lo spargimento di sangue”.
Sul fronte opposto, il presidente turco Erdoğan si prepara al un trionfale bagno di folla a Baku, dove il 10 dicembre dovrebbe sfilare alla testa della imponente parata militare organizzata dal regime di Ilham Aliyev per celebrare la vittoria sull’Armenia. Una vittoria preparata a lungo e resa possibile dal vertiginoso incremento della spesa militare di Baku che, grazie alla ricchezza di idrocarburi del suo sottosuolo, si è potuta permettere di dedicare risorse sette volte superiori a quelle stanziate da Erevan. Mentre la popolazione azera cresceva costantemente fino a 10 milioni, diventando più di tre volte quella armena, il PIL di Baku, pompato dalle esportazioni di idrocarburi, è arrivato a 46 miliardi di dollari contro i 12 di Erevan. Sulla vittoria azera ha influito il forte sostegno turco, ma anche la mancanza di sostegno all’Armenia di alcuni suoi storici alleati.
La prudenza dell’Iran
Non è stata solo la Russia a evitare ogni intervento risolutivo prima che la vittoria azera fosse patente. Anche l’Iran, storico alleato di Erevan, ha avuto un atteggiamento più che prudente. Storicamente schierato con l’Armenia, durante il breve ma cruento conflitto l’Iran ha permesso ad alcuni convogli carichi di armi russe destinate a Erevan di attraversare il suo territorio. In generale Teheran contrasta l’approccio espansionista dell’Azerbaigian e della Turchia, che hanno fortemente investito sulla promozione delle spinte separatiste tra gli iraniani di lingua e cultura azera. Ma stavolta l’Iran è stato molto cauto, proprio per non indispettire decine di milioni di iraniani di etnia azera sensibili alla propaganda nazionalista panturca.
Ad ottobre decine di migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere l’Azerbaigian contro l’Armenia nelle regioni a maggioranza azera ma anche a Tabriz e a Teheran, al grido di “il Karabakh ci appartiene”, impensierendo non poco il governo. Poi quattro imam di altrettante regioni abitate da popolazioni azere (l’Azerbaigian orientale e occidentale, Ardebil e Zanjan) hanno reso pubblico un documento in cui si affermava: «Non c’è dubbio che il Nagorno-Karabakh appartenga all’Azerbaigian e che la mossa del suo governo per riconquistare la regione sia completamente legale, secondo la Sharia, ed in linea con quanto previsto da quattro risoluzioni dell’Onu». Come se non bastasse, la guida suprema iraniana, Ali Khamenei ha dichiarato che l’Azerbaigian ha tutto il diritto di “liberare i territori occupati” dall’Armenia. Inoltre, gli abitanti dell’Azerbaigian sono per lo più sciiti, come i persiani, e l’Iran spera prima o poi di poter aumentare la propria influenza oltreconfine, contrastando il legame sempre più stretto tra Baku da una parte e Ankara e Tel Aviv dall’altro.
Sullo schieramento della Repubblica Islamica nel recente conflitto nel Caucaso ha sicuramente influito la decisione del governo Pashinyan di stabilire normali relazioni diplomatiche con Israele, nonostante Tel Aviv si sia sempre rifiutata di riconoscere il genocidio turco degli armeni per non turbare gli ottimi rapporti con Ankara. Del resto, anche se Erdoğan si atteggia a difensore dei palestinesi, la Turchia e Israele hanno molti interessi comuni, a partire dall’ostilità nei confronti dell’Iran.
Israele sostiene Baku
Quella di Pashinyan è stata una mossa azzardata – probabilmente dettata dalle pressioni di Washington e di altri sponsor internazionali – e controproducente. Se da una parte ha insospettito e allontanato l’Iran, dall’altra è arrivata proprio mentre si palesava il massiccio sostegno israeliano ai preparativi bellici azeri. La contraddizione è esplosa pubblicamente all’inizio di ottobre, pochi giorni dopo l’inizio della guerra, quando Pashinyan ha stigmatizzato l’offerta israeliana di inviare aiuti umanitari a Erevan e ha provocatoriamente invitato il presidente israeliano a mandarli ai mercenari jihadisti schierati dalla Turchia per dare man forte alle truppe azere. Dopo pochi giorni Pashinyan ha ritirato il suo ambasciatore in Israele, accusando quest’ultimo di armare coloro che stavano bombardando i civili armeni. Effettivamente, Israele è il primo fornitore di armi dell’Azerbaigian, anche più della Turchia.
Secondo lo “Stockholm International Peace Research Institute” (Sipri), tra il 2006 e il 2019 il cosiddetto Stato Ebraico avrebbe venduto a Baku circa 825 milioni di dollari di attrezzature militari, circa il 60% del totale delle importazioni belliche del paese. Recentemente, le imprese israeliane hanno riempito gli arsenali azeri dei micidiali droni suicidi “Harop” e dei missili “Lora” che hanno sbaragliato le forze armene in pochi giorni. I primi sono di fatto dei droni-missili teleguidati in grado di inseguire l’obiettivo e di rimanere in volo per ben 9 ore; i secondi hanno invece una gittata di quasi 300 km, capaci di colpire quindi a grande distanza. Come se non bastasse, Israele ha fornito a Baku anche le micidiali bombe a grappolo M095 DPICM, vietate dalle convenzioni internazionali ma impiegate più volte dall’esercito azero nei bombardamenti sull’Artsakh (Amnesty International ne ha denunciato l’uso su Stepanakert il 3 e 4 ottobre).
Sono due i motivi che hanno spinto Israele a sostenere in maniera così massiccia l’Azerbaigian. Il primo è di carattere strategico: l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan fornisce a Tel Aviv ben il 40% delle sue importazioni petrolifere. Il secondo motivo è di carattere logistico, militare e geopolitico: il principale obiettivo di Israele nella regione è quello di isolare l’Iran e di contenerne l’influenza. Obiettivi condivisi con la Turchia, che pure con l’Iran è dovuta scendere a patti sulla gestione del Nord della Siria dopo aver fallito l’obiettivo del regime change a Damasco.
Secondo varie indiscrezioni, Tel Aviv avrebbe ottenuto da Baku il permesso di utilizzare il territorio azero per spiare il confinante Iran e per lanciare eventuali attacchi contro le installazioni nucleari di Teheran